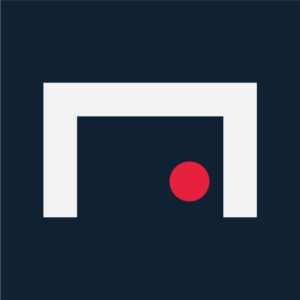Insegnare pallavolo nei campi profughi in Grecia: il racconto di Ruth
Che lo sport possa essere un’ancora di salvezza, un salvagente a cui aggrapparsi, una ragione di vita, non è una novità per noi pallavolisti.
C’è un luogo dove questa verità è ancora più palese, più vivida: i campi profughi sull’isola greca di Lesbo.
A raccontarci questa esperienza è Ruth Zijlstra, pallavolista olandese di 23 anni che, per 3 mesi, ha lavorato nel campo come volontaria. È stata proprio lei, insieme ai colleghi, a montare la prima rete.

«Le prime settimane di lavoro al campo ho pensato “La vita è ingiusta” – racconta Ruth sul suo blog – . Io, da volontaria, ogni sera potevo tornare al mio appartamento con studio e letto king size. Potevo andare a fare shopping, farmi una doccia calda e scegliere che film guardare. Nel frattempo migliaia di persone scappate da guerra e fame vivevano a pochi metri da me nelle tende, nel fango, in perenne attesa di un visto per entrare in Europa».
Abbiamo raggiunto Ruth con una videochiamata; è tornata da poco in Olanda e ci ha raccontato la sua avventura dall’inizio.
«Ai primi di settembre (ero in Grecia da una settimana) un incendio ha devastato il campo profughi di Moria. 13 mila persone, tra cui molti bambini, che già vivevano in condizioni precarie, sono finite per le strade».

«Nelle settimane successive sono state montate nuove strutture. Abbiamo lavorato senza sosta per mitigare i disagi. Uno dei problemi peggiori è però la noia: le persone, chiuse in quarantena a seguito del COVID, non hanno nulla da fare e passano le giornate a rimuginare solo sui loro problemi. Così ho pensato di proporre loro lo sport».

«In quanto pallavolista, sono naturalmente portata a costruire campi da pallavolo ovunque – scherza -. Abbiamo individuato una collina con uno spazio più o meno in piano; è lì che abbiamo montato il primo campo, usando ruote, pietre, pali e filo da cantiere».
«Convincere le persone a giocare è stato più difficile del previsto. Abbiamo cominciato con gli uomini single: loro vivono tutti insieme, dormono uno a fianco a l’altro, senza alcuna privacy. Il morale a terra sembrava avergli tolto ogni energia. Siamo andati tenda per tenda e abbiamo persuaso i primi. Il gioco li ha rinvigoriti, sono tornati subito a sorridere e presto, con il passaparola, ne sono arrivati altri».

«Poi è venuto il momento delle donne. Con loro è stato ancora più difficile. Abbiamo provato distribuendo volantini, ma non compariva mai nessuna. Non avevamo capito che, in certe culture (come ad esempio quella afghana), lo svago per le donne non esiste».
«Una volta ho chiesto a una ragazza: “Qual è il tuo sport preferito?”. E mi sono sentita stupida, perché non ne conosceva nessuno».
«Sono tornata da loro ogni giorno, cercando di costruire la fiducia. Abbiamo iniziato a giocare al chiuso in un tendone, perché non volevano essere guardate da altri uomini. Poi abbiamo proseguito all’aperto».

«Erano incredibilmente imbranate. Alcune non avevano mai nemmeno preso in mano un pallone. Ma la soddisfazione dopo le prime settimane nel vederle correre, urlare e divertirsi è stata indimenticabile. Hanno cominciato le figlie; poi sono arrivate le madri. Persino una nonna di 70 anni».

«La loro cultura spesso le rinchiude in casa per proteggerle, ma le rende anche molto sole. Lo stare insieme, il giocare insieme, gli dà forza».
«C’era anche chi conosceva già la pallavolo. Una mamma dall’Iran, 24 anni e 3 figli, la amava alla follia e le mancava molto. È stata la sua chance per schiacciare di nuovo un pallone dopo tante disavventure».

«Nei campi profughi ci sono spesso problemi tra persone di diverse nazionalità. Durante lo sport, invece, non ce n’è mai stato nessuno: tutti vogliono giocare in squadra con quello più bravo, e non importa da dove provenga».
«Abbiamo avuto il supporto di un’associazione, si chiama Let’s Keep the Ball Flying, che ci ha inviato dall’Olanda materiale per giocare: reti, pali, palloni, vestiario».
«Sarei dovuta rimanere in Grecia poche settimane. Quello era il piano iniziale. Alla fine sono rimasta 3 mesi. Ora sono di nuovo a casa, in Olanda, ma una parte del mio cuore è là e ci sarà sempre. C’è ancora così tanto da fare… spero di poter aiutare anche a distanza, con i progetti dell’associazione».
«Noi tutti dovremmo imparare a essere molto più grati di ciò che abbiamo. Anche io ero quella che, in palestra, si lamentava se un pallone era troppo gonfio o sgonfio. È incredibile come un pallone, qualsiasi pallone, possa davvero regalare la felicità».
Grazie a Silas Zindel di Eurorelief per le splendide foto.