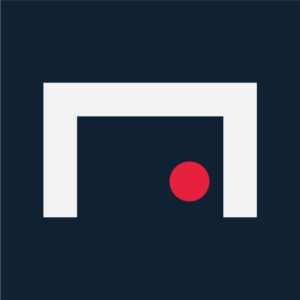«Sul tetto del mondo». La prima volta dei Fenomeni di Velasco
30 anni fa, con la prima vittoria dei ragazzi di Velasco, si faceva la storia dello sport italiano e si cambiava per sempre questo sport.
«Bernardiiiii!! Bernardiiiii!!! Campioni del Mondo!!! Sul tetto del mondooo!!! È il grande momentooo!»
Jacopo Volpi
Nella sua pur gloriosa carriera di giornalista sportivo, dubito che Jacopo Volpi abbia avuto un momento che l’ha entusiasmato di più, in cui ha fatto più fatica a controllare l’umana emozione. Emozione che scaturiva dall’assistere ad un momento storico per il nostro sport, per la pallavolo italiana, ma più in generale per la pallavolo e basta.
Era il 28 ottobre 1990, eravamo in Brasile, con il titolo di Campioni d’Europa conquistato l’anno prima in Svezia a darci molto più credito di qualsiasi altra edizione in passato. Ma la realtà è che i favoriti erano altri per quell’edizione.
Julio Velasco: il condottiero dall’Argentina
Si diceva (come ricorda ancora oggi Julio Velasco) che gli italiani non avessero la potenza dei russi, la mostruosa atleticità dei cubani, il sistema di gioco e la coesione degli americani, la tecnica e fantasia dei sud-americani…invece da quel momento, i russi fummo noi. Diventò quasi una parola d’ordine.
Velasco perfezionò e portò all’estremo l’efficienza di un gruppo di ragazzi, di giocatori, che era stata plasmata anche da quel genio sovente incompreso di Aleksander Skiba, allenatore polacco capace di portare ad un livello incredibile un materiale umano che per talento e mezzi non ha avuto probabilmente pari in alcuna nazionale.
Un periodo di grandi cambiamenti
Certo, il volley era molto cambiato in quegli anni ’80, era cresciuto molto. In Italia aveva sempre avuto una forte tradizione, ma cominciò anche un mecenatismo (sull’onda di piazzamenti più che dignitosi) e di una maggior potenza economica che di lì a breve, grazie ai successi dei Fenomeni, ci avrebbe dato ciò che abbiamo ancora oggi dopo trent’anni: il campionato più importante del mondo.
Non vi fu quindi un solo fautore di quel successo, ve ne furono molti, come sempre accade nelle svolte epocali di un qualsivoglia campo dello scibile. Un concorrere di eccellenze che, ben sfruttate, crearono quella squadra, quella generazione capace di cambiare una disciplina, di vincere quasi tutto quello che c’era a fronte di una concorrenza mostruosa.
Eppure, molto di quel merito sicuramente fu di Julio Velasco, di questo coach argentino visionario, determinato, adamantino, che cambiò ogni certezza, ogni modus operandi che il nostro volley aveva, impresse una trasformazione totale del concetto di collettivo, di giocatore, di pallavolo.

Parola d’ordine: atteggiamento
Ma soprattutto Velasco cambiò una cosa nei nostri giocatori: l’atteggiamento.
Il web è strapieno dei suoi video e dei suoi seminari, di cosa fu il suo togliere la cultura dell’alibi, infondere un approccio mentale totalmente diverso, dove l’essere spietati verso sé stessi, andava a braccetto con il non sentirsi mai battuti in partenza contro nessuna squadra, nessun avversario.
Sognare in grande ma guardare ai dettagli, lavorare quotidianamente, inseguire un obbiettivo pretendendo il meglio da ognuna delle componenti in gioco.
Fu qualcosa che si materializzò nel lavoro in palestra ma anche fuori, nella dieta, nell’aprirsi anche a gastriti straniere ove fosse necessario, il tutto sempre cercando di uscire dalla comfort zone, di essere adattabili eppure anche fedeli a sé stessi.
Il concetto di specializzazione
La specializzazione fece capolino in modo prepotente. Fino a quel momento era regnato il concetto di “universale”, di giocatore intercambiabile; Velasco invece decise che occorreva mettere ogni giocatore dove poteva essere più efficace per la squadra, dove rendeva di più.
L’America di Kiraly e Timmons, di Doug Beal, aveva mostrato come contrastare e vincere lo strapotere fisico dei sovietici, dei brasiliani, degli argentini. Velasco ampliò quel progetto, basato su programmazione, specializzazione e un diverso metodo di allenamento; lo portò ad un livello superiore, creò un collettivo che in quel Mondiale, fu capace letteralmente di scalare le montagne russe.
Un inizio in chiaro-scuro
E dire che l’inizio era stato sì buono, ma non esaltante. Alcuni giocatori (Zorzi e Tofoli su tutti) non erano proprio al top. In allenamento le cose non andavano come sarebbero dovute andare. Ancora oggi i reduci di quella rassegna ricordano le sfuriate di Velasco, l’insoddisfazione per ciò che vedeva e non corrispondeva alle sue aspettative.
«Sono stato sovente severo e duro con loro – ha scritto nel suo libro su quel mondiale – ma mai li ho sottovalutati». Era vero.
Con il Camerun si partì bene: 3 a 0. Un piccolo cedimento con i possenti bulgari, un 3 a 1 che fu un piccolo campanello d’allarme non colto e che portò alla batosta con i terribili cubani del “Diablo” Joel Despaigne: una sconfitta 3 a 0 senza discussioni.
Eppure fu quel 3 a 0 la chiave di volta, e fu lo stesso Velasco a spiegare il perché: l’atteggiamento.
«Il giorno dopo la partita tutti erano sicuri che mi sarei infuriato – disse – invece gli dissi che ero ancor più sicuro che avremmo vinto il mondiale, perché avevano gli occhi della tigre. Avevano giocato male? Si. Ma avevano giocato, contro una Cuba straordinaria, non avevano mai mollato, avevano sempre cercato di ribaltare la situazione. Gli feci i complimenti. Lì cambiò tutto».

Risorgere dalle ceneri
Si, lì cambiò tutto. O meglio, lì l’Italia crebbe di set in set, partita in partita. Superò lo scoglio della Cecoslovacchia, poi di quell’Argentina che con Kantor e Conte si trovò invece spiazzata da una regia sensazionale del nostro Paolo Tofoli, palleggiatore come ve ne sono stati pochi nella storia.
Fu una vittoria agrodolce per il nostro Coach argentino, ma fu un quarto di finale che ci catapultò nella semifinale contro i padroni di casa, contro quel Brasile che al Maracanazinho inizialmente ci travolse con i suoi assi e con un pubblico a dir poco infervorato.
«Ricordate – disse Velasco ai suoi prima del match – loro giocheranno alla morte, il pubblico ci sarà contro e forse l’arbitro di fregherà anche qualche punto. Mentalmente preparatevi a questo e al fatto che comunque dobbiamo vincere. Nessun alibi». Invece per fortuna l’arbitraggio fu molto corretto. Ma quanta fatica!
La sfida infinita del maracanazinho
Tande, Carlao, Negrao e gli altri, il primo set travolsero gli azzurri. Ma Bernardi, Cantagalli, Gardini, capitan Lucchetta, Tofoli e tutti gli altri non si persero d’animo, nonostante la bolgia che non permetteva neppure di sentire Velasco nel time out.
Il secondo e terzo set furono azzurri, poi nel quarto arrivò la reazione degli uomini carioca. Velasco giostrò i cambi, del resto la panchina azzurra con De Giorgi, Anastasi, un Giani che già era stato importante nei primi match, Bracci, Masciarelli e Martinelli, permetteva anche questo.
Il tie-break di quella partita infinita, in cui l’Italia andò oltre ogni ostacolo, ancora oggi è vivo nella memoria per l’ultimo punto: per quel primo tempo che capitan Lucchetta piantò nei tre metri con il muro brasiliano che si aspettava ben altro in un momento così fatidico del match. Il suo urlo a mano alzata, fu qualcosa di più di un urlo: fu la rivendicazione di un’ambizione, la presa di coscienza definitiva di un gruppo dalla forza mentale e tecnica pazzesca.
Una finale che cambiò tutto
Poi la finale. Già. Quella finale che tutti (persino io che ero troppo piccolo per ricordarla) abbiamo visto, ci è stata narrata, è diventato monumento audio-visivo della cultura sportiva di questo paese, passaggio di testimone tra due diversi modi di vedere il volley.
Cuba era una squadra pazzesca, fisicamente e atleticamente mostruosa, dove però a regnare sovrana era l’idea che tutto passasse per le mani di quell’incredibile fuoriclasse chiamato Joel Despaigne, in quel momento senza dubbio il più grande giocatore del mondo.
Inoltre, come ancora oggi, i caraibici erano dediti ad una pallavolo tanto spettacolare quanto sovente immersa in un narcisismo davvero troppo instabile, troppo fine a sé stesso.
Nel primo match avevano disintegrato l’Italia in virtù di un attacco superiore e di una di quelle giornate dove anche in difesa erano stati veramente puntuali. Ma quella sera si trovarono di fronte ad un’altra Italia.
Era una squadra che sapeva quello che voleva e sapeva come ottenerlo: insieme.

«Vale come un pallonetto»
«Vale come un pallonetto» diceva Velasco ai suoi mentre i cubani si esibivano in attacchi sui tre metri fine a sé stessi, vincendo per 15 a 12 un primo set in cui soprattutto Bazooka Cantagalli fu martoriato in ricezione.
Ma fu gloria effimera per i caraibici. Cantagalli tornò in campo come una furia, fu tra i migliori infine di una nazionale che esibì un gioco di squadra dalla solidità pazzesca, paziente, con una ricezione perfetta che permise a Tofoli di distruggere ogni velleità del sistema muro-difesa cubano.
A poco a poco, l’efficienza in attacco, la battuta, un sistema difensivo sempre più puntuale, disintegrarono le certezze dei cubani. Il secondo e terzo set, furono dominati per 15 a 11 e 15 a 6 dagli azzurri.
Nel quarto set parve non esserci storia: sul 10 a 5 però gli uomini di Velasco subirono un crollo di attenzione che favorì il ritorno di una Cuba guidata da un Despaigne come sempre straordinario.
Sul tetto del mondo
Si arrivò addirittura al 14-13. Velasco cambiò, girò, ruotò, le provò tutte. Poi finalmente l’Italia prese in mano di nuovo la situazione, ma per ben otto volte il match ball non si concretizzò.
Poi, poi arrivò la “palla in più” su cui Velasco aveva basato la sua concezione di pallavolo, quel lavorare quotidianamente per prendere, difendere, attaccare, toccare a muro un pallone in più che facesse la differenza tra vittoria e sconfitta.
Gardini tocca a muro l’attacco cubano, Lucchetta lo difende, Tofoli alza per Bernardi, per quel ragazzo che ancora non lo sapevamo ma sarebbe diventato qualcosa di unico. E Lollo, 22 anni appena compiuti, spacca il muro cubano, ci fa diventare Campioni del Mondo, avvicina all’infarto Jacopo Volpi con cui abbiamo cominciato questo racconto.

L’eredità dei fenomeni
Quella vittoria ha cambiato tutto. Ha reso l’Italia il centro di questo sport a dispetto di isolate corazzate dell’est, ha dato il via ad una sfilza di successi che fece dell’Italia il simbolo pallavolistico di quel decennio. Quella Generazione dei Fenomeni che vinse tre mondiali e una quintalata di altre medaglie.
Solo l’Olimpiade, quei cinque cerchi maledetti da chissà quale divinità per noi, rimase un miraggio dolorosamente decorato di argento e bronzo ma mai d’oro. Ma non importa.
A trent’anni da quella serata, da quella finale, possiamo dire che non saremmo stati gli stessi, nessuno di noi, senza Velasco e i suoi ragazzi.
Senza quella vittoria dubito il volley sarebbe diventato il secondo sport di questo paese; noi forse manco l’avremmo praticato.
Di certo non si sarebbe costruito un progetto tanto virtuoso quanto attuale, nel ricordarci l’importanza del concetto di gruppo, di cultura del lavoro, di quanto solo insieme si può superare ogni difficoltà e raggiungere il più pazzesco dei traguardi.