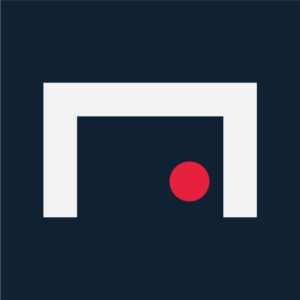I 55 anni di Paolo Tofoli: «Una volta palleggiare era più divertente»
Paolo Tofoli spegne 55 candeline. Il suo nome evoca ricordi, evoca vittorie e momenti magici per chiunque ami la pallavolo e non solo. Riporta alla mente le gesta di un palleggiatore capace di cambiare il nostro gioco; di essere mente e faro di quella Generazione di Fenomeni che ha trasformato il Volley italiano per sempre.
Paolo ci risponde al telefono dal mare che, a quanto ci dice, poco serve per proteggersi da questo caldo assurdo, da questo agosto infuocato, che ci ha dato però un’Olimpiade che verrà ricordata a lungo.
Da poco abbiamo salutato queste Tokyo 2020. Quali sensazioni ti ha lasciato la rassegna?
Ovviamente rimane l’amaro in bocca. Tutti si aspettavano una grande prestazione, arrivare perlomeno tra le prime quattro. Penso che l’Italia avesse le potenzialità per farcela, per arrivare a tiro di medaglia; poi ovviamente di che colore era difficile prevederlo. Purtroppo non siamo riusciti a superare l’Argentina. No, direi che per la pallavolo non è stata una grande Olimpiade. Ora sicuramente bisognerà rifondare la Nazionale con i giovani visto che Osmany ed Ivan non ci saranno più e toccherà a De Giorgi; ma credo che si debba guardare oltre Europei e Mondiali. Bisogna creare una progettualità con punto d’arrivo a Parigi 2024. Si dovranno provare volti e nomi nuovi, magari accettando di perdere qualche partita in più, ma con l’obbiettivo di farli crescere assieme. È l’unica strada per vincere l’Olimpiade.
In Italia dopo la delusione di questa Olimpiade, qualcuno ha tirato fuori la parola “maledizione”. Che ne pensi?
Che siamo arrivati tante volte vicini, ma mai riusciti a vincere. Non è facile vincere un’Olimpiade.. bisogna arrivare in forma. Poi è un ambiente totalmente diverso da Mondiali o Europei: ci sono molte più distrazioni. Ma non è un alibi, vale pure per gli altri. Penso che ci siano le potenzialità per fare qualcosa di buono, in fondo con l’Under 21 abbiamo vinto molto recentemente, quindi abbiamo sicuramente materiale in prospettiva. Ma non parlerei di maledizione no: a vincere un Olimpiade bisogna arrivarci con mentalità e idee giuste. Certo noi abbiamo avuto anche problemi, penso all’infortunio di Zaytsev, ma sicuramente dovevamo far meglio. Una medaglia olimpica avrebbe dato un enorme spinta al movimento. Purtroppo le nostre squadre a Tokyo non sono riuscite ad avere successo; la Pallavolo femminile forse aveva più chance di arrivare tra le prime tre. Ma non puoi puntare su un singolo, per quanto forte, come Paola Egonu. Una squadra è fatta di coralità. Ora c’è da sperare che queste sconfitte diano lo stimolo ad un cambiamento.
Da Italia Argentina di pochi giorni fa a quel quarto di finale a Brasile 90, forse la partita della tua definitiva consacrazione. Cosa ricordi di quel match?

Beh dall’altra parte c’era un grandissimo come Kantor, che giocava in Italia dall’84. Quella era un Argentina fortissima dove i migliori giocavano tutti in Italia. Quel match fu la prima consacrazione, a quei tempi eravamo outsiders. Avevamo sì vinto gli Europei nell’89, ma a Seul 88 eravamo arrivati 11esimi: non eravamo certamente favoriti per quel Mondiale. Da quella partita con l’Argentina ci fu un crescendo, lì prendemmo consapevolezza della nostra forza.
Per me fu importante perché si era parlato molto già dall’Europeo di un dualismo con Fabio Vullo. Vullo vinceva dappertutto con il club e io no; però Julio Velasco credeva in me, voleva fossi io il palleggiatore. Non avessimo vinto la finale nell’89, sia io che Velasco saremmo stati attaccati ferocemente.
Con l’Argentina fu una grande partita; c’era tensione perché uscire ai quarti per entrambe sarebbe stato qualcosa di difficile da accettare, ma vincemmo. Poi ci fu il match con il Brasile, che fu la partita veramente decisiva secondo me; lì ci rendemmo conto di cosa potevamo fare, che potevamo vincere il Mondiale. Un 3 a 2, contro 25mila tifosi, ci fece guardare alla sfida con Cuba con altri occhi, anche se nel girone o in amichevole ci avevano battuto sempre. Del resto Velasco voleva anche per le amichevoli le squadre più forti, facevamo tournée ovunque per questo, per farci diventare più forti mentalmente e fisicamente. Però si, fu da quel match con l’Argentina che cominciammo a crederci.
342 presenze in azzurro, ben 27 medaglie conquistate. Quale tra queste ti è più cara?
Tutte hanno significato qualcosa, ma credo che sia normale ricordare le prime. L’Europeo dell’89 in Svezia e poi naturalmente il Mondiale dell’anno dopo, anche perché fu grazie a queste due vittorie che riuscimmo a far conoscere la pallavolo al grande pubblico italiano. Basti pensare che prima di allora, la pallavolo era messa nelle seconde pagine della Gazzetta; dopo invece cambiò tutto, i media si accorsero di noi. Per strada ci riconoscevano, c’era chi ci disse di aver cominciato a giocare grazie a noi, una bellissima sensazione.
Sei stato in campo per ben 24 anni. Quanto è cambiato il ruolo del palleggiatore?

È cambiato tanto perché è cambiata la pallavolo. Acosta nel 98 decise per il rally point system e questo ha rivoluzionato tutto, ha modificato il modo di giocare. Prima c’erano molti più schemi e tatticamente la situazione era molto più complessa, anche perché con il cambio palla, le partite duravano un’eternità. Adesso ogni palla è punto, ed è quindi importante metterla per terra ogni volta. Non sei mai sicuro di aver vinto, bastano un paio di errori e tutto torna in discussione.
Oggi il palleggiatore deve giocare molto più veloce, la pipe è molto più importante di una volta, non si usano più tanto gli incroci ma si spinge di più coi primi tempi. In posto 4 e 2 lo stesso, si viaggia a velocità siderali.
Si, direi che in generale si chiede di essere più rapidi; però io credo che ci si divertisse di più una volta a palleggiare. Basta pensare che il più grande di tutti, Kim Ho-Chul, aveva qualcosa come 90-100 schemi. Però è anche vero che oggi, grazie alle statistiche, ai video, si può studiare meglio l’avversario.
Rimango però dell’idea che sia soprattutto importante studiare come gioca la tua squadra, prima di concentrarsi sugli avversari. Per me il palleggiatore rimane un ruolo in cui la mente è importantissima: devi essere un po’ psicologo, devi capire al massimo i tuoi compagni, chi hai attorno, a chi affidare la palla sul 24 pari, lo schema migliore, la palla a chi darla quando scotta. Poi bene o male il palleggiatore fa da tramite con l’allenatore, ed è la persona a cui questi si affida di più anche per parlare di squadra e gioco. Ora che alleno, io parlo con il palleggiatore più che con tutti gli altri. A volte, quando finisco la sessione video, mando via tutti e tengo solo i palleggiatori per discutere di come impostare il gioco, di cosa fare, di cosa non fare, che palla giocare o no.
Tu sei sempre stato definito il “Fenomeno Normale”. Oggi c’è più “divismo” nel volley?
Io sono di carattere riservato. In squadra, ai tempi di Velasco, non avevamo prime donne, anche perché credo che troppi galli nello stesso pollaio, come si dice, non vadano bene. Oggi però abbiamo i social e onestamente non so dove saremmo arrivati, quanto più famosi, più importanti saremmo diventati se all’epoca delle nostre vittorie ci fossero stati Facebook, Instagram, Twitter e il resto. In quest’epoca appena dici una cosa in pochi secondi fa il giro di tutto il mondo; lo stesso dicasi per ogni foto, notizia. Certo molti di noi, di quel gruppo, erano famosi, ma niente a che vedere con quello che i moderni media permettono oggigiorno.
Da ormai dieci anni hai intrapreso la carriera di allenatore. Da dove pensi che bisogna far ripartire la nostra pallavolo?
Io penso questo: i giovani italiani ci sono. La formula della A2 e della A3 permette a tanti ragazzi italiani di giocare, di crescere. Certo è vero che ci sono tanti stranieri oggi rispetto ai miei tempi; nella nostra Serie A è normale vederne 4 fissi in campo, quando giocavo io erano 2. Però secondo me avere gli stranieri permette di tenere alta la competitività; se vuoi avere il campionato più bello del mondo, come è il nostro, non puoi chiudere le porte alle stelle internazionali. In più costringi l’italiano a guadagnarsi il posto, a doverselo sudare contro il giocatore straniero, a non avere la “pappa pronta” come si dice.
Di base, secondo me, il vero problema è che le società non danno molta fiducia ai giovani. E poi si è persa la cultura del costruire, si vuole subito vincere, non si ha mai pazienza.