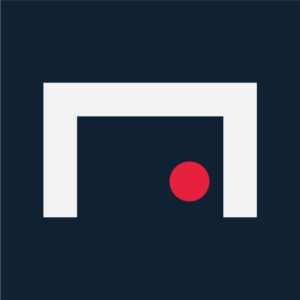«Se non puoi cambiare il mondo, cambia come lo vedi». La storia di Bas van de Goor
La storia della pallavolo italiana è colma di vicende di grandi campioni che, con il loro passaggio, hanno lasciato un segno. Alcuni di loro si sono fatti conoscere e rispettare in campo, altri sono stati in grado di farsi amare fuori. Solo pochi hanno avuto la capacità di fare entrambe le cose e di rimanere a modello per molte generazione. Sebastiaan Jacques Henri van de Goor, detto Bas, è stato uno di questi.
Centrale olandese classe 1971, Bas van de Goor ha giocato per 8 stagioni nel nostro campionato dove si è fatto amare dai tifosi di Modena e Treviso per la sua personalità e per le sue doti in campo. L’attacco e il muro dal centro sono stati la sua arma sul taraflex. Nella sua carriera, costellata da successi e vittorie, ha collezionato tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e tre Champions League. A questo già ricco palmarés si aggiunge anche la medaglia d’oro olimpica conquistata in finale, spezzando il cuore dell’Italia di Julio Velasco ad Atlanta ’96. Per tutti i suoi meriti, nel 2018 è stato inserito nella Hall of Fame della pallavolo mondiale.
Personalmente ha dovuto affrontare diverse sfide che lo hanno portato a diventare sempre più combattivo e forte: prima la diagnosi del Diabete di tipo 1 e poi il linfoma. Esperienze che lo hanno portato a creare una fondazione che porta il suo nome e che si pone l’obiettivo di supportare nello sport tutte le persone affette, come lui, dal diabete.

Quattro chiacchiere con Bas van de Goor
Come ti sei avvicinato al mondo della pallavolo?
«Ho giocato un po’ a calcio, ho fatto nuoto, ho praticato judo, tennis e tennis tavolo. Quando avevo 9-10 anni i miei amici giocavano tutti a pallavolo così sono andato con loro. Nella mia classe sono sempre stato il più alto e quindi ad un certo punto quando a 15 anni ho toccato i due metri, gli allenatori mi hanno visto e ho cominciato a fare più allenamenti e a lasciare tutti gli altri sport. Da lì è cominciato tutto, mi piaceva il mondo della pallavolo olandese: ho giocato nella squadra regionale, poi in quella provinciale, poi nella nazionale juniores e anche in quella successiva. Ho fatto parte della squadra che si è giocata gli europei 1990, e nell’88 avevo già giocato gli europei juniores a Bormio contro il Giangio, che all’epoca era già una stella a Parma. Per noi tra i migliori c’erano Giangio, poi un vuoto enorme, e poi un paio di russi, un po’ di vuoto ancora e poi tutti gli altri. È stato molto bello poi trovarmi a giocare con lui nella sua stessa squadra».
Il ruolo che ti ha accompagnato nel corso della tua carriera è sempre stato quello del centrale. Cosa ti faceva divertire maggiormente di questo ruolo e cosa invece ti riusciva più difficile fare?
«È come nel gioco del calcio, chi non sa giocare va in porta, e chi è il più alto nella pallavolo finisce al centro. Io ho cominciato un po’ così, perché essendo alto ovviamente era chiaro che sarei andato al centro ed era abbastanza normale; perché non è che ero alto e poi anche fisicamente a posto per giocare bene e veloce. Dopo tanti allenamenti, ad un certo punto ho cominciato a credere che potevo fare un passo in avanti».
«Quando facevo parte della squadra juniores invece, non avevo idea di poter arrivare così in alto; per me la pallavolo era ancora un hobby e non avevo ancora il sogno di voler andare in Serie A o alle Olimpiadi. In Olanda ho frequentato l’Isef dove ho avuto la possibilità di praticare tutti gli sport, ho sviluppato tutto il corpo, non solo dal punto di vista della teoria ma anche della pratica, e questo mi ha aiutato nella mia carriera pallavolistica perché per una persona che è alta 2 metri e 09 mi muovevo bene. Lì è arrivata anche la scelta di cambiare posizione: nel Mondiale del 94 ho giocato come banda contro l’Italia; abbiamo perso la finale, 14-1 all’ultimo set. Con servizio su di me di Cantagalli, con cui poi ho giocato a Modena. Alla fine ho capito che il centro era il mio posto».

«In Nazionale ho giocato 8 anni con Peter Blangè e 8 anni in Italia con Fabio Vullo: se c’è un sogno per un centrale, è giocare otto anni consecutivi con loro, perché loro due non sono solo stati bravissimi palleggiatori ma a loro piaceva anche giocare con il centro – anche adesso ci sono palleggiatori bravissimi, ma che non sfruttano il centro come facevano loro – e per un centrale non c’è cosa migliore. Ci sono poi centrali che sono più muratori e quelli che sono più attaccanti; io sono un attaccante e quindi volevo svilupparmi anche sul muro e con Daniele Bagnoli all’inizio sono riuscito credo a farlo abbastanza bene, mi ha insegnato. Mentre in Olanda si migliora tecnicamente giocando, in Italia devi studiare, devi leggere, si gioca in una maniera diversa e questo mi ha aiutato tanto».
«Il cambio per me più brutto è stato il libero, perché per uno che faceva il centrale, me la cavavo abbastanza bene nella ricezione. Una volta quindi che è arrivato il libero, altri centrali sono diventati più forti. Per dirti, mio fratello è un bravo giocatore in prima linea ma in seconda linea faceva fatica; il libero quindi a lui ha fatto bene, a me invece no. L’introduzione di quella regola per me è stata difficile».
In Italia ancora oggi sei ricordato dai tifosi di tutte le squadre, ma soprattutto di Modena e Treviso dove sei ancora ben voluto e amato. Che emozioni leghi agli anni in cui hai vissuto qui, possiamo dire, da italiano acquisito? Se ti dico Italia cosa ti viene in mente?
«Se mi chiedono cosa è stata la cosa più bella della mia carriera, dico sempre due cose: le Olimpiadi del ‘96 e gli otto anni in Italia, perché per me è stato un periodo importante dove sono arrivato a Modena da giovane senza aver vinto nulla, e mi sono integrato bene nella squadra e nella città, capitale della pallavolo. Con Vullo, Cantagalli, Bracci, Modena era una squadrona tanto che ad un certo punto avevo capito che anche giocando in banda – si parlava dell’arrivo di Andrea Giani ed erano gli anni ’94 – sarei stato il settimo uomo, perché potevo giocare sia in banda che al centro. Giangio non è arrivato e così sono entrato al centro: fin da subito c’è stato tanto entusiasmo. Ovviamente poi il primo anno quando non giochi bene, ci sono i giornali che scrivono notizie ogni giorno, in Olanda non esistono a questo livello, e ho dovuto abituarmi a convivere con questo. Ogni anno torno in Italia e l’ho portata in l’Olanda dove organizzo con gli amici serate italiane a base di pizza».
«Qualche settimana fa durante la diretta sulla pagina di Modena Volley ho visto per la prima volta alcune immagini delle partite e dell’entusiasmo del pubblico. Per me è stato bellissimo, sia perché quasi mai avevo visto quelle immagini e anche perché i miei figli non sanno nulla, non hanno idea di cosa è stato».

Nella tua carriera con la nazionale olandese hai vinto anche un oro olimpico. Cosa ti ricordi di quell’esperienza? Che effetto ti fa sapere che a Tokyo non ci sarà il pubblico?
«Abbiamo provato a rigiocare la partita 10/12 anni dopo in Olanda perché per noi è stata una bella partita, ma poi non ci siamo riusciti. Quella finale è stata per gli italiani amara, per noi è un grande onore sia stata scelta come miglior momento sportivo del secolo».
«Guardando a Tokyo, un mio amico della federazione di atletica mi ha raccontato che molti atleti non hanno voglia di andare e questo non è qualcosa che si addice all’appuntamento sportivo più grande del mondo. Ci sono atleti che hanno voglia di farsi l’esperienza, se tutti vanno lì e nessuno ha voglia di partecipare.. Prova a pensare che ad esempio se un giocatore della squadra italiana è positivo e non può giocare, e di conseguenza anche tutti gli altri non possono giocare, è una situazione davvero difficile».
Ti va di farci un pronostico sulle prossime Olimpiadi? Chi pensi arriverà fino alla fine?
«Faccio fatica a fare un pronostico, perché credo che se ti dico una squadra, quella sia la mia speranza sulla squadra che vincerà. Mi spiace molto che l’Olanda non ci sia, sia nel maschile che nel femminile, e quindi tiferò per il mio paese preferito numero 2, l’Italia. Spero proprio che l’Italia possa vincere le Olimpiadi, farei festa con loro».
Dopo le tue due più grandi emozioni da sportivo, qual è stata la più grande emozione da non sportivo?
«Ovviamente la mia famiglia, sto con Nicole da quasi trent’anni. Abbiamo quattro bambini di 17, 15, 11 e 9 anni e certamente sono ancora più importanti della vita sportiva».
«Inoltre c’è la mia fondazione. Quando mi è stato diagnosticato il Diabete di Tipo 1 non ne sapevo niente e nemmeno sapevo a chi chiedere informazioni e alla fine dopo un anno ho deciso di creare una fondazione. Fino ad ora posso confermare sia stata una scelta molto positiva. Ero diventato il team manager della squadra di Apeldoorn di cui sono originario, dove ho giocato per tre anni dopo aver salutato Treviso e dove ho voluto diventarne il direttore sportivo, ma dopo mezzo anno ho smesso. Inizialmente credevo fosse qualcosa che mi avrebbe dato energia ma invece così non è stato; la pallavolo mi dà energia con i pantaloncini, non con la cravatta. E quindi ho smesso e dopo qualche giorno sono andato a fare un viaggio dove ho conosciuto la mia attuale collega con cui dopo nove mesi abbiamo inaugurato la fondazione dove fino ad ora sta andando tutto bene. Lavoriamo in 10/12 persone, in questo tempo un po’ brutto stiamo cercando di tirare avanti».
«La fondazione mi dà invece tanta energia perché ci sono diverse persone che mi hanno detto che grazie a lei e alle esperienze offerte, la loro vita è migliorata e questo ovviamente mi fa piacere sentirlo e porta anche tanta soddisfazione».

Quali sono stati i progetti che avete realizzato? Quali i programmi futuri?
«All’inizio abbiamo visto che in Olanda ci sono circa 10 mila bambini con il Diabete di Tipo 1 e per loro abbiamo cominciato a organizzare i giochi sportivi e gli sport camp. Adesso, questa cosa la facciamo in misura molto più elevata».
«Dal momento che però ci sono anche 100 mila adulti con Tipo 1, per loro abbiamo provato a migliorare la loro qualità della vita per far capire che quando viene diagnosticato il Diabete di tipo 1, si può fare comunque tutto ciò che si vuole. Sono da sapere alcune cose per gestire bene qualche situazione, ma si può. Per loro abbiamo portato avanti tanti progetti: siamo saliti sul Kilimangiaro con 8 persone a cui era stato diagnosticato il diabete di tipo 1; abbiamo coinvolto anche chi ha il Diabete di tipo 2 – un tipo che colpisce le persone maggiormente in sovrappeso e più anziane, e in Olanda sono 1 milione – a fare una challenge in Marocco; per il terzo progetto siamo andati invece in Islanda dove abbiamo trovato un vero e proprio teatro dove 12 persone con diabete di tipo 1 o 2 hanno raccontato come gestiscono la loro vita, come coinvolgono i dottori, gli infermieri e gli altri professionisti ed anche questa iniziativa ha avuto molto successo».

«Queste sono solo due o tre cose dove può partecipare un numero limitato di persone e quindi abbiamo deciso di non farli più. Per comunicare vanno bene, ma il nostro obiettivo è quello di essere più aperti e coinvolgere più persone. Abbiamo cominciato allora a organizzare delle raccolte fondi e abbiamo fatto una trentina di avvenimenti: andiamo a camminare, abbiamo fatto il cammino di Santiago de Compostela, o facciamo la maratona di New York o una gara di mountain bike, o il nordic ski o andiamo a fare pattinaggio in Austria. In queste occasioni ci sono sempre 20/30 persone che vengono con noi, raccolgono fondi che poi noi riusciamo ad utilizzare per organizzare tutte le attività pensate per i bambini. Ovviamente non abbiamo potuto farlo in questi mesi e per il Covid non possiamo nemmeno organizzare i camp per i bambini…».
«Come terza cosa, la fondazione aiuta anche i medici di base. Per intenderci, in Olanda siamo organizzati con due linee: la prima fa da filtro con le persone per capire chi ha bisogno di cure più semplici e chi deve invece andare dallo specialista. In Olanda, il 97% delle cure finisce nella prima linea, e quello che facciamo noi è spiegare alle persone quanto sia importante lo stile di vita. Ad esempio, vediamo come trattamento andare a camminare tranquillamente. Abbiamo 250 posti in cui aiutiamo il dottore di base a far muovere la gente, che ha paura dell’ipoglicemia, e non sa come fare. E questo è qualcosa che sta andando avanti, anche perché le persone hanno visto cosa vuol dire non stare bene».
«Ovviamente poi quando possiamo farci pubblicità, lo facciamo volentieri: un anno abbiamo partecipato al giro d’Italia iniziato in Olanda portando la maglia rosa da Milano a Apeldoorn, andando in bicicletta per 10 giorni. Io poi sono direttore sportivo di qualche evento della federazione olandese e il prossimo anno quando organizzeremo il mondiale indoor femminile, la nostra fondazione sarà la charity partner del torneo e della federazione».

La tua vita non è sempre stata così facile. Nel 2003 infatti ti è stato diagnosticato il Diabete di Tipo 1, nel 2016 il linfoma. Come ti hanno segnato queste difficili esperienze e cosa hai imparato nell’affrontarle? Cosa pensi potresti insegnare ai tuoi figli?
«Non so se posso insegnare ai miei figli come si affrontano queste situazioni; io faccio quello che faccio e loro lo vedono. Il fisico qualche volta mi ha lasciato indietro, ho avuto l’epatite, il diabete, la tia a Treviso, il linfoma. So che il corpo può stare male e si può rompere, ogni tanto si ripara, ogni tanto un po’ meno. Ad esempio, da un anno a questa parte porto gli occhiali e vuol dire che non funzionano più come devono, e così anche il pancreas. Quando invece ti capita una cosa come il linfoma, la prima settimana vedi tutto nero, non pensi più al mese dopo, ma al giorno o all’ora dopo. Meno male che abbastanza presto ho avuto la sensazione che i dottori fossero ottimisti, mi davano abbastanza fiducia».
«La mia idea di affrontare la situazione era quella non avere idee: ho avuto due situazioni nella quali ho potuto fare la differenza, andare dal dottore giusto e chiedere la cura giusta e quest’ultima non la so, ne sono loro a conoscenza. Loro mi hanno detto cos’era e quale cura dovevo fare e quindi lì ho tolto tutto e sono andato in chemioterapia. Quando finisce e ti fanno vedere che è tutto ok, per tornare alla normalità ci ho messo un anno e tre mesi; dopo mezzo anno potevo andare con tranquillità a lavorare. Ci sono però persone che vogliono andare subito velocemente.. io lascio succedere ciò che deve succedere, se ho la sensazione che posso andare a fare un po’di pesi, di fisica o andare a lavorare vado, sennò no. La mia idea era non avere idee, succede quello che succede e questo mi ha aiutato a tornare a lavorare al 100% in quell’arco di tempo».
«Quello che forse la famiglia potrebbe imparare guardandomi, è che non puoi preoccuparti troppo delle cose in cui non ha influenza, devi stare concentrato su ciò che puoi influenzare. Questo non vuol dire che io non abbia avuto momenti difficili, ma adesso posso guardare avanti. Anche con il diabete, ci sono tante persone che non accettano di averlo; io dopo un giorno l’ho accettato, con il linfoma invece è stato più difficile, ma successivamente ci sono riuscito. Ma non perché mi facevo molta forza nel fare questo, mi è venuto naturale, non ho fatto fatica a comportami così».
«Mentre stavo male il supporto arrivato dall’Italia mi ha fatto molto bene, ho sentito cantare dal palazzetto, mi hanno fatto un pranzo a sorpresa quando ero in Italia per le vacanze con la famiglia. Tornare in un luogo che mi ha dato tanto mi ha scatenato solo bei ricordi».
Hai avuto tanti illustri compagni, con chi sei particolarmente legato ancora oggi?
«Giangio, Marco Bracci, Fabio Vullo sono ex compagni di squadra con cui mi trovo ogni volta che torno in Italia. Essendo fuori dal giro della pallavolo in questo momento, quando nel 2019 sono andato alla finale degli Europei ho incontrato tanti ex giocatori, vado d’accordo con tutti. Quando sono stato male ho avuto tanti messaggi dagli italiani come Lorenzo Bernardi, ma anche serbi e francesi».
Che consiglio daresti a tutti quei giovani che si trovano in un momento di difficoltà, fisica ma non solo, e decidono di rinunciare ad un proprio sogno, come potrebbe essere quello di giocare ai massimi livelli, perché vedono in questa decisione la via più naturale?
«Io credo che se hai un sogno, la cosa più importante sia il fatto che ti piaccia fare quella cosa perché se la fai per un altro, è meglio smetterla. Se tu non sei uno che si sveglia la mattina e ha voglia di giocare a pallavolo, a calcio, a basket ecc ecc, è meglio smetterla perché diventerà sempre più dura andando sempre più in alto. Ad un certo punto si ha bisogno dell’energia interna visto che la strada è lunga. Se ti diverti e arrivi ad un ostacolo, come ad esempio quando fai la 110 m di atletica ad ostacoli, se ne colpisci uno che ti trovi davanti puoi dire “non posso andare avanti” però lo puoi anche prendere in spalla e continuare anche con due o tre. Io ne ho avuti un paio e me li porto sulle spalle e vado avanti; non sono fissi, bisogna trovare il modo per vivere assieme con quell’ostacolo, farlo diventare proprio».
«Se riesci a fare questo, poi diventare più forte. Non puoi cambiare il mondo, puoi cambiare come lo vedi e questo l’ho imparato anche dai miei ex compagni di squadra modenesi quando sono arrivato come un giovane e nel momento difficile dove loro erano i più forti e tutti guardavano a loro, loro pensavano solo una cosa “Cosa devo fare per fare questo punto”. Una volta che hai questa concentrazione, ne fai la tua forza».